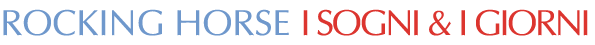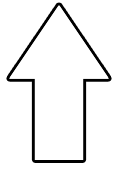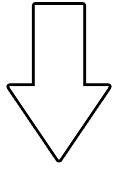TORITON
Beati quelli che lavorano sempre ispirati. In particolare gli artisti e nel mio caso i parolieri. L’ispirazione fa vedere tutto chiaro: la storia da sviluppare, le immagini, lo stile e il punto in cui inserire il nome del protagonista, che di solito coincide con il titolo della sigla. Quando capita questa magia le parole arrivano da sole in poche decine di minuti. In meno di un’ora il testo è fatto e restano le rifiniture: si elimina qualche ripetizione, si sostituisce un aggettivo o una congiunzione, si migliora, se occorre, la musicalità dei versi anche secondo il tipo di voce e di artista.
Il testo di una canzone per un cartoon si può realizzare anche solo con il mestiere, cioè con l’esperienza delle sigle andate a buon fine. Tuttavia più volte quel piccolo dono che cade dal cielo mi aiutò a trovare un modo felice d’esprimermi, una specie di codice immediatamente comprensibile dai bambini di ogni età.
L’ispirazione facilita la creatività. Mi è capitato spesso di comporre avendo le ore contate per arrivare al dodicesimo chilometro della via Tiburtina, guardare quindici minuti di filmato prendendo appunti, tornare a casa e partorire, anche di notte, la mia piccola opera fatta di parole. Per “Toriton” il caro Olimpio, croce e delizia di oltre dieci anni di collaborazione, non mi concesse nemmeno il tempo di tornare in RCA per la consegna. Completai il testo alle due del mattino e arrivai alle Pagine Gialle regolarmente in ritardo. Fui richiamato dal capo, mi avvicinai ancora insonnolito al tavolo da disegno, presi il telefono e chiamai Olimpio per rassicurarlo sull’esito del lavoro e chiedergli un appuntamento. Lui rispose che alle due del pomeriggio sarebbe entrato in studio e avrebbe iniziato a registrare, quindi non c’era il tempo per vedersi. Ma potevo dettare il testo a Jimmy Tamborrelli che si trovava lì in ufficio. E così feci. Eravamo ad aprile del 1981, all’epoca – è proprio il caso di usare questo termine – le comunicazioni via fax erano rarissime e non esistevano né il WEB né la posta elettronica. Solo alcuni potevano disporre del telex, perciò nei casi urgenti non restava che il telefono e qualcuno che scrivesse pazientemente in stampatello.
Nel rivedere il foglio, che Olimpio ha conservato per tutti questi anni, con il testo di “Toriton” e la calligrafia di Jimmy, ho provato un po’ di nostalgia e ho sorriso pensando al produttore severo e sbrigativo che non era riuscito a separarsi da un pezzo di carta che testimonia come nascevano le nostre canzoni. La fretta, il poco tempo a disposizione per ognuna delle tappe che portavano alla registrazione in studio, era la caratteristica prevalente del modo in cui si realizzavano le sigle. Tante erano le ragioni, soprattutto il gran numero di soggetti coinvolti: la casa di produzione del cartone, la rete televisiva, la casa discografica, un eventuale produttore esterno alla RCA, gli studi, l’autore della musica, il paroliere, gli interpreti, i tecnici del suono… Ciascuno partecipava al grande gioco per raggiungere il suo obiettivo anteponendo le proprie necessità. E a Olimpio spettava il non facile compito di coordinare le fasi di lavorazione ascoltando tutti e decidendo poi in splendida solitudine come mettere insieme le tessere del mosaico.
Venerdì 3 aprile, come sempre alle cinque del pomeriggio, timbrai il cartellino in uscita. Inebriato dall’aria primaverile e dalla felicità per una delle mie fatiche notturne che si concretizzava in un disco, salii sulla Citroen Dyane arancione e avviai il motore senza ricorrere alla manovella di cui era dotata per i casi d’emergenza. La mia Dyane era entrata nell’ottavo anno di vita e manifestava alcuni sintomi di stanchezza come l’accensione stentata, soprattutto alle basse temperature. Perciò quella partenza ottenuta al secondo o terzo giro di chiave confermò il buonumore con cui andavo a incontrare Olimpio e i Rocking Horse al Titania, lo studio preso in affitto per “Toriton”.
Tornavo in quel quartiere della periferia romana dopo dieci anni. Conoscevo bene molte delle stradine strette e lunghe che si affacciano sulla via Boccea. Cercando il numero 131 di via Prospero Santacroce riconobbi le case popolari tra le quali avevo passeggiato sottobraccio a Teresa, la ragazza di cui mi ero innamorato in un tempo lontano e che aveva abitato in una palazzina a pochi passi dalla rampa di accesso al Titania. Mentre cercavo parcheggio ripensai a Teresa, alla nostra storia che era finita e a lei che non viveva più in Italia. Poi mentre scendevo per la rampa chiusi la porta alla malinconia e suonai il campanello di un’altra porta, fatta di legno e acciaio, messa lì dove una volta doveva esserci stata la saracinesca di un’autorimessa o di un magazzino.
Intorno al mixer trovai, oltre al fonico, Olimpio, Dougie e Jimmy Tamborrelli. Di là dal vetro che separa la regìa dalla sala di registrazione intravidi Stefano Senesi, il bravissimo tastierista che aveva iniziato a suonare con Renato Zero, in tour e in studio, e la cui assenza all’ultimo momento aveva causato l’entrata in scena di Dougie e di Jimmy come interpreti di “Candy Candy”. Sapevo che la musica di “Toriton” era stata composta da Jimmy e non mi meravigliai della sua presenza ma non riuscivo a capire perché, se c’era Dougie a cantare, non ci fosse anche Mike Fraser a suonare. A parte “Lucy”, fino ad allora i brani dei Rocking Horse erano stati firmati Meakin-Fraser e Mike con il suo stile al pianoforte e alle tastiere aveva contribuito a caratterizzare il suono della band.
Non vedevo Dave Sumner e Mick Brill né uno dei due batteristi che avevano suonato nelle sigle precedenti; ma forse la spiegazione era semplice. Chitarra, basso e batteria fanno parte della ritmica e vengono registrati per primi. A metà del secondo giorno di lavoro era molto probabile che i tre avessero già terminato i loro turni. Mentre Stefano rafforzava la ritmica con dei brevi inserti di piano, Dougie e Jimmy seguivano la registrazione provando il canto a voce bassissima per non disturbare l’ascolto in regìa. “Niente male l’idea di riproporre il duo che ha portato così tanta fortuna a Candy!”, pensai. Ma era evidente che Stefano aveva preso il posto di Mike. Sentivo di non aver nulla da obiettare sulla scelta di Olimpio: Senesi e Fraser erano, come tuttora sono, due musicisti di razza, ricchi entrambi di estro e sensibilità, tuttavia la loro forma espressiva lasciava un’impronta diversa. E diverso era l’impasto di suoni che avevo avvertito appena messo piede al Titania, certamente non quello di “Mysha” e di “Lulù”.
La mia memoria non è infallibile, al contrario contiene lacune e incerti ricordi. Senza le agende di Olimpio e il racconto diretto dei protagonisti non avrei potuto dare a queste pagine una corretta cronologia e dei contenuti veritieri. In più per trovare riscontri o fugare dei dubbi mi sono avventurato di tanto in tanto nel mare di internet alla ricerca delle pagine che riportano notizie e curiosità sul mondo delle sigle dei cartoni tv e degli artisti che le hanno create. In rete c’é tutto e il contrario di tutto. Ci si può trovare l’oro, nel senso dell’informazione, e ci si può imbattere in fiumi di parole in libertà zeppe d’inesattezze o in storie inventate di sana pianta.
Da qualche parte è stato scritto, e col tempo è diventato un fatto attendibile mai smentito dall’interessato, che Aldo Tamborrelli detto “Jimmy” deve il suo soprannome alla maestria con cui suonava la chitarra fin dagli esordi e allo stile multiforme che gli consentiva di passare con naturalezza dal country al rock, dal jazz al funky, al blues, al pop. Insomma, per dire che era un mostro di bravura i colleghi musicisti avrebbero iniziato a paragonarlo al mitico Jimi Hendrix. Da lì a chiamarlo con lo stesso nome il passo sarebbe stato breve. A parte la sua indubbia destrezza con lo strumento, il resto è falso, probabile frutto di un equivoco che si è trasformato in leggenda.
Aldo Tamborrelli, classe 1944, aveva manifestato fin da ragazzino una naturale predisposizione per la chitarra e a quindici anni – era il 1959 e Hendrix avrebbe iniziato a calcare le scene solo sei anni più tardi – fu notato da un impresario dell’avanspettacolo e della rivista, che lo volle tra le sue attrazioni.
Tutti i ragazzi del mondo impazzivano per Elvis Presley e per il rock and roll e quelli italiani non facevano eccezione. Il nostro paese subiva l’invasione pacifica delle musiche, dei dischi e degli artisti che arrivavano dagli Stati Uniti. Ciò che veniva da oltre oceano era sinonimo di originalità e modernità e aveva facile presa sul pubblico dei giovanissimi. Così molti cantanti nostrani o i loro produttori sceglievano nomi d’arte che evocavano l’America e le sue stelle dello spettacolo. Mentre la melodia pareva avviata sul viale del tramonto esplodeva la moda degli urlatori, e con essa si affacciavano alla ribalta Tony Dallara (Antonio Lardera), Little Tony (Antonio Ciacci), Baby Gate (Mina Mazzini) solo per citare alcuni artisti che iniziarono la professione inglesizzando il proprio nome. Perciò scoperto il talento di Aldo fu obbligatorio per l’impresario mutarne il nome in “Jimmy Tamborrelli, reduce dai successi…” di una non meglio precisata “tournee australiana”. Così recitava il manifesto della prima esibizione di rilievo del futuro autore e arrangiatore di “Toriton”, scritturato dalla compagnia dei fratelli De Vico. In caratteri decisamente più piccoli compariva sullo stesso manifesto il nome italianissimo di Lino Banfi, ai suoi primi passi di una lunga e fortunata carriera.
Impossibile a questo punto non riflettere almeno un po’ sulle strade misteriose dell’esistenza e sul caso che fa incrociare i destini di due artisti in un poster e in un teatro, all’alba della loro professione. Impossibile non interrogarsi sul perché uno sia diventato meritatamente un attore tra i più popolari in Italia e l’altro, dopo aver firmato oltre mille e cinquecento brani musicali, alcuni dei quali di straordinario successo come “Rocking Rolling” interpretato da Scialpi nel 1983, debba invece esibirsi cantando canzoni romane e napoletane in un noto ristorante del centro di Roma. Forse la risposta sta nel detto “Ognuno è artefice della propria fortuna”. Con il candore e l’onestà che lo contraddistinguono Jimmy stesso mi ha raccontato che un giorno di tanti anni fa l’attrice Chelo Alonso aveva deciso di produrlo come cantante annunciandone il lancio sulle pagine del “Messaggero”. Tuttavia, alla data fissata per la registrazione, Jimmy cambiò idea e non si recò in studio. “Stavo a Rimini con Loredana Bertè e Renato Zero. Il giorno dopo dovevo andare a registrare e non mi sono presentato. Non mi andava più… e poi non ho mai creduto nella mia voce, anche se mi dicevano che ero bravo. Ma tu hai presente doversi preoccupare della propria immagine, parlare con i giornalisti, fare i servizi fotografici, andare da una città all’altra, cambiare albergo quasi ogni notte? Lucio, io so’ pigro! Non mi va di rinunciare alle abitudini. Quand’è finito il lavoro mi piace stare in casa, tranquillo, con la televisione e un po’ di vino, solo la sera però. Io so’ un pantofolaio. Quello che mi diverte davvero è comporre, scrivere musica, soprattutto su commissione. Posso stare anche dieci ore di seguito al computer ad inventare melodie, a fare un arrangiamento, ma non chiedermi di andare alle feste, ai ricevimenti, per farmi vedere… Una volta mi hanno invitato da una parte, era una cosa importante. Ho detto di sì, mi sono pure vestito bene, ho preso la macchina, sono arrivato al bar dove mi aspettavano e ci sono passato davanti senza fermarmi. Sono tornato a casa ”.
Aldo “Jimmy” Tamborrelli è rimasto ciò che è sempre stato: un bravo ragazzo, ora con i capelli bianchi misti a quelli biondi, un chitarrista eccezionale che ha insegnato tanto a tanti e un gran lavoratore della musica. Già, perché per lui si tratta solo di lavoro sia che scriva un album di canzoni per un esordiente sia che crei piccole perle per animali da palcoscenico come Patty Pravo o Rita Pavone sia che componga la colonna sonora di un film, le musiche di una commedia teatrale o la sigla di un cartone animato come “Toriton”. Solo un lavoro, certo, ma con l’entusiasmo e il divertimento dei suoi quindici anni, quando il suo nome fu stampato per la prima volta su un manifesto. Non si è mai montato la testa, nemmeno oggi che in Internet sono molte le pagine che parlano di lui. É stupito dell’interesse che le sue sigle suscitano ancora dopo tanto tempo, se ne meraviglia con i ragazzi che lo ringraziano per averle scritte e aggiunge che i complimenti andrebbero rivolti a chi ha fatto i testi. Questo è Jimmy: eterno innamorato della musica che quando è costretto a parlare di sé non pronuncia mai la parola arte anche se la onora con il suo talento da oltre mezzo secolo.
Venerdì 3 aprile 1981, ore 20,00. Dopo due ore al Titania le mie perplessità sull’assenza di Mike Fraser, Mick Brill, Dave Sumner, Derek Wilson e Marvin Johnson iniziarono a trovare una risposta, mentre chiacchieravo un po’ con Dougie e un po’ con Olimpio. Benché le loro spiegazioni fossero vaghe, iniziai a convincermi che non c’era niente da capire e che, semplicemente, erano stati chiamati altri musicisti, tutti bravissimi ma diversi da quelli che avevano suonato in “Mysha” e in “Lulù”. E il loro compito consisteva nel realizzare un buon disco, anzi due, visto che il programma di lavoro prevedeva di registrare entro martedì 7 aprile anche “Il Fantastico Ranch del Picchio Giallo”. Quanto alla mia idea che a cantare sarebbero stati Dougie e Jimmy insieme, mi accorsi di essere completamente fuori strada: per entrambe le sigle la voce solista sarebbe stata quella di Dougie.
Nella mente di Olimpio Petrossi i Rocking Horse, come i Superobots, erano un gruppo aperto, un contenitore di musicisti e di autori; i Rocking Horse erano però ritenuti più adatti ai cartoni potenzialmente preferiti dalle ragazzine. Nessuno in RCA decise mai a tavolino i nomi dei componenti del gruppo, nessuno stabilì mai che certi solisti o certi autori diventassero il nucleo forte e stabile di quel contenitore. Quello che avvenne fu in parte casuale e in parte dovuto alle musiche scelte di volta in volta. Se Olimpio prendeva un brano di Douglas Meaking e Mike Fraser li faceva affiancare dal meglio della colonia di musicisti inglesi presenti in RCA. Se invece, come nel caso di “Toriton”, la scelta cadeva su un altro autore, Olimpio si sentiva libero di chiamare i musicisti più adatti e liberi da altri impegni. Fu per questi motivi che al Titania trovai alle tastiere Stefano Senesi e non Mike Fraser, Glauco Borrello al basso invece di Mick Brill e Roberto Di Stefano alla batteria al posto di Derek Wilson o di Marvin Johnson. Quanto alla chitarra neanche un produttore autorevole come Olimpio avrebbe mai affidato a Jimmy l’arrangiamento di una sua canzone chiedendogli di rinunciare al ruolo di chitarrista, seppure a favore di un solista eccellente come Dave Sumner.
Nessuno decise mai se il timbro delle voci dei Rocking Horse dovesse risultare morbido, dolce e con qualche punta in falsetto come in “Candy Candy”, “Mysha” e “Lulù” o maschio e più aggressivo come in “Toriton”. Il tipo di voce era per lo più determinato dal protagonista del cartoon e dall’arrangiamento. In “Toriton”, arrangiata da un rocker come Jimmy, il canto di Dougie si adeguò alle sonorità metalliche che dominavano in tutto il brano. Dougie cantò a voce piena, con l’accento virile e un po’ cattivo già usato in “Il Grande Mazinger” e ripetuto ancora come “Rocking Horse” in “Forza Sugar” e poi come “Superobots” in “Gordian”. Toriton, protagonista della serie, era il giovanissimo tritone che di avventura in avventura lottava con terribili mostri marini per riportare la pace negli oceani. Dunque anche l’indomito ragazzo dai capelli verdi armato di un magico pugnale contro ogni tipo di malvagi e prepotenti richiedeva un’interpretazione vocale forte, vigorosa: e Dougie ci azzeccò in pieno.
Una curiosità: gli assolo di Jimmy all’inizio, a metà e alla fine dei due minuti e cinquantotto secondi di sigla sembravano presi in prestito da Dave Sumner. Questo elemento unito alla presenza di Dougie come cantante e alla mia come paroliere confermò una sicura continuità di stile tra i primi Rocking Horse e quelli di “Toriton”.
La nostra vita di fabbricanti di canzoni e di sogni, chiusi ermeticamente in una sala di registrazione, tagliati temporaneamente fuori dal mondo reale, scorreva in parallelo alla nostra esistenza di persone per il resto del tutto simili a chi faceva un lavoro diverso o a chi un lavoro già allora non riusciva a trovarlo. Anche noi eravamo attraversati da quegli anni di cambiamenti striscianti e radicali, anni di un definitivo riflusso nel privato dopo il ciclone collettivo del sessantotto che aveva fatto nascere molte speranze e che molte promesse non era riuscito a mantenere. Il 1981 fece emergere contraddizioni, aperture e chiusure nel dialogo politico e commerciale tra i popoli, minacce alla pace e aspettative fiduciose, violenze riuscite e sventate, apparizioni e miracoli.
La Cina comunista lasciò un varco nella grande muraglia dell’ideologia post maoista consentendo l’ingresso di uno dei maggiori simboli del capitalismo occidentale, una fabbrica della Coca Cola. In Italia le Brigate Rosse portavano a compimento il sequestro del consigliere regionale della Campania Ciro Cirillo e rapivano il generale Dozier. Il 12 aprile gli Stati Uniti avrebbero dato nuovo impulso alla conquista dello spazio e ai voli orbitali con il battesimo del Columbia, il secondo Space Shuttle, e di lì a pochi mesi avrebbero ricevuto il consenso del nostro governo alla colonizzazione di un altro pezzo d’Italia e d’Europa con l’installazione a Comiso di una base di lancio di missili Cruise. Gli israeliani invece i missili li usarono sul serio il 7 giugno, quando distrussero con un raid aereo un reattore nucleare dell’Irak di Saddam Hussein. Il presidente egiziano Sadat veniva ucciso dal terrorismo islamico, uno squilibrato falliva l’attentato alla vita di Ronald Regan, Alì Agca sparava e una mano misteriosa, qualcuno disse quella della Vergine, deviava la traiettoria della pallottola che altrimenti avrebbe ucciso il Papa. La stessa Vergine, secondo l’estatico racconto di sei bambini dell’ex Jugoslavia, iniziava le sue apparizioni a Medjugorie.
Terminata la registrazione di “Toriton”, Aldo “Jimmy” Tamborrelli, protagonista dell’età di mezzo dei Rocking Horse, continuò a correre da uno studio di registrazione all’altro vivendo il suo periodo più prolifico di compositore, arrangiatore e virtuoso della chitarra. Fermato da tre collassi dovuti all’attività frenetica e agli orari impossibili imposti da quel periodo di vendite record, l’ultimo della discografia italiana, non si arrese e ricominciò ogni volta a suonare, a innamorarsi, a fare figli e a non andare alle feste dove era invitato. Nelle pause del lavoro al Titania Dougie vestiva i panni del falegname per costruire un enorme Mazinger di legno, stoffa e cartapesta con cui avrebbe stupito i bambini accorsi al Teatro Sistina il 16 aprile per applaudire “Mister Candy Candy” e i nuovi eroi dei cartoni. Io che mi dividevo tra la musica e l’impiego come disegnatore pubblicitario non potevo immaginare che prima della fine di quell’anno complessivamente fortunato sarei tornato al Titania e avrei provato una delle delusioni più cocenti della mia attività di paroliere.
Ero andato nello studio di via Prospero Santacroce per incontrare Mia Martini. Olimpio, che aveva scelto un brano di Armando Trovajoli per la sigla di una telenovela, aveva pensato a me come autore del testo e a lei come cantante. La stupenda interprete di “Almeno tu nell’universo” uscì dallo studio dove stava lavorando vestita con un completo jeans, senza un filo di trucco e con grandi occhiali da sole. Fatte le presentazioni prese il foglio con il testo, lo lesse in poco più di un minuto e me lo restituì liquidandomi con poche parole inequivocabili. Disse che non avevo capito niente e che non avrebbe cantato quello che avevo scritto perché non c’entrava nulla né con lei né con la musica di Trovajoli. Restai muto. Olimpio preferì non aggiungere altro, non interferire; era in imbarazzo per me, era molto dispiaciuto. Io mi sentivo peggio che se fossi stato preso a schiaffi. Col senno di poi, rileggendo quel testo riconobbi che le frasi e le immagini usate erano un po’ sdolcinate, di un romanticismo di maniera. In quel caso l’angelo dell’ispirazione non era volato sul soffitto della mia stanza.
Dopo tutto l’affanno, il lavoro notturno, la lavata di testa del capoufficio e l’urgenza di un testo dettato per telefono passarono cinque mesi prima dell’uscita di “Toriton” nei negozi di dischi, a settembre del 1981. La sigla del tritone in missione per la pace fu pubblicata come lato B di “Lulù” e grazie a questa accoppiata vendette settantamila copie del 45 giri originale. Altri quarantamila dischi di cover incisi da altre etichette discografiche arrivarono nelle case dei nostri fan nei mesi seguenti. Le sigle dei cartoni animati stavano vivendo il loro momento magico e se un brano era di qualità e veniva realizzato bene le soddisfazioni, anche quelle economiche, non mancavano.
Per me l’avventura dei cartoon era iniziata un po’ per gioco e un po’ per caso un paio di anni prima. Senza che nessuno me lo avesse chiesto avevo scritto un testo su Peter Pan utilizzando la musica di un amico cantautore, Piero Darini, all’epoca sotto contratto con la RCA. E avevo convinto Piero a fare un provino cantato da noi due in una saletta di registrazione a pochi metri dall’ufficio di Olimpio Petrossi. Non ci sarebbe stato granché da aggiungere. La base musicale era pronta poiché si trattava di uno dei brani su cui io e il mio amico avevamo già lavorato. Dovevamo soltanto cantare il testo, così, tanto per vedere che cosa ne sarebbe venuto fuori. Per farci quattro risate ma non solo. Ci davamo arie da artisti impegnati ma ci eravamo accorti del gran movimento che si stava creando in RCA intorno alle sigle dei cartoni. Heidi aveva scalato la Hit Parade e Jeeg Robot era diventato un tormentone. Dissi a Piero: “Proviamoci… per capire se siamo capaci di fare questo genere di cose…“.
Era quasi sera, gli uffici RCA apparivano come un reticolo di stanze e corridoi deserti. Avremmo lavorato indisturbati. Stavamo cantando “E’ un bambino e ci sa fare… Peter Pan sa già volare…” quando si aprì la porta del piccolo studio. Era Olimpio. “Beh?! Che state a fa’?” “Ah… niente” risposi “E’ solo una prova, una canzone su Peter Pan. Per divertirci, per fare un po’ di casino”. In effetti ci stavamo divertendo, non cantavamo né di cuori infranti né di problemi esistenziali ma di una specie di folletto che si librava nell’aria e andava all’avventura volando dal cielo della sua stanza fino agli oceani per sfidare il terribile capitano Uncino. Olimpio, che era rimasto sulla soglia, sembrava perplesso e incuriosito. Chiese a Piero di riavvolgere il nastro, riascoltò la canzone e alla fine mi disse di seguirlo nel suo ufficio, dove prese una cassetta e l’inserì nel lettore. Era il provino dell’“Ape Magà”. Mi spiegò che la base musicale era quasi ultimata. Avevano un testo che non lo soddisfaceva pienamente, perciò se volevo avrei potuto provare a scriverne uno migliore. Per l’indomani. Fu la prima notte che passai in bianco a causa di una sigla e fu anche la porta attraverso la quale entrai scoprendo il mondo dei cartoni tivù. Quelle parole su Peter Pan inventate fuori degli schemi e cantate con l’allegria dei ragazzi che imbracciano una chitarra e si liberano di tutti i pensieri furono la scintilla che accese un piccolo grande fuoco che ancora manda più di una luce.
Per la verità quando scrissi quel “Peter Pan” che nessuno mi aveva commissionato non mi ero posto il problema di come si crea il testo di una sigla. Avevo seguito l’istinto. Ma quando arrivai a casa con il provino dell’“Ape Magà”, iniziai a pensare… e a chiedermi: “E adesso? Come si fa? Un testo per bambini. E questa volta non è per giocare. Devo stare attento alle parole. I bambini non hanno lo stesso vocabolario dei ragazzi o degli adulti. Rischio di non farmi capire e poi non è solo questione di parole. I bambini sono meno complicati, credo, senza quelle sovrastrutture mentali che abbiamo noi.”. Insomma, mettevo e rimettevo la cassetta avanti e indietro per farmi entrare la musica in testa, ma non mi decidevo a iniziare. Tirai giù un testo finto, una cosa senza significato, solo un insieme di strofe e ritornello in versi con la metrica giusta e con gli accenti dove devono stare, tanto per avere sotto gli occhi la forma e la lunghezza del testo da inventare. Poi la lampadina si accese.
“Gabriele! Farò finta di scrivere per Gabriele. Ha quasi sei anni… Chi vedrà “Magà” in televisione ha suppergiù la sua età… Sì, adesso faccio ripartire la musica e immagino di averlo qui davanti a me e di cantare per lui! Ma in un modo che gli arrivi subito, in quel minuto e mezzo che durerà la sigla.”.
Andò tutto bene. E questa è l’occasione per ringraziare mio nipote Gabriele di essermi entrato nella mente in una sera del ‘79 e avermi guidato la mano mentre scrivevo “Hip! Urrà! – Per Magà – L’ape vagabonda!…” e di avermi suggerito le parole che avrei scritto nelle sigle di tutti gli anni a venire.