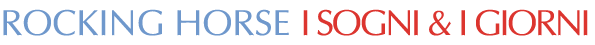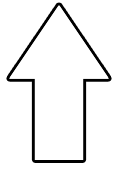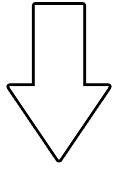L’ISOLA DEL TESORO e IL DR. SLUMP E ARALE
Robert Louis Stevenson scozzese di Edimburgo scrisse “L’isola del tesoro” nel 1883 all’età di 33 anni e divenne un romanziere di successo. Quasi cento anni dopo, era il 25 novembre del 1981, i Rocking Horse entravano in sala di registrazione per realizzare la sigla musicale del cartoon ispirato alla sua celebre opera. Chiamato a scrivere il testo, anch’io avrei compiuto 33 anni, ma solo di lì a tre mesi. La coincidenza mancata di poco tra i nostri compleanni potrebbe essere letta oggi come un segno premonitore.
Dopo il boom di “Candy Candy” e le belle affermazioni con “Lulù”, “Mysha” e “Toriton” i Rocking Horse salivano rapidi verso la notorietà. Io non ero riuscito a piazzare alcuni testi per Mina, per Morandi e per l’indimenticabile Mia Martini ma avevo firmato per artisti diversi un bel numero di brani, dodici dei quali erano sigle. Per questo, accanto a Dougie e ad altri autori con cui avrei dovuto competere, ero nella sala riunioni delle Edizioni Musicali, guardavo la videocassetta dell’”Isola” e prendevo appunti con la tranquillità di chi inizia un nuovo lavoro sapendo di poter contare non più sulla sola voglia di arrivare, ma anche su una buona dose di esperienza.
La nuova serie era stata acquistata dalla RAI e ciò significava soldi sicuri. Inoltre sapevo che avremmo avuto tutti più tempo per i nostri provini. Il giorno dopo comprai il libro di Stevenson e iniziai a leggerlo prendendo altri appunti. Dovevo saperne il più possibile, la programmazione in RAI era un’occasione unica, forse irripetibile, di raggiungere il grande pubblico e chissà, magari il primo posto in classifica. Se Olimpio me lo avesse chiesto ero pronto a collaborare con Dougie e Mike ma pensavo anche all’eventualità di presentare un brano tutto mio, parole e musica.
A nove o dieci anni avevo iniziato a scrivere poesie. Ne ho conservate una dozzina di cui un paio in dialetto romanesco. Ricordo una mattina in prima media che il professore di italiano per aiutarci a familiarizzare con la metrica ci assegnò un compito a casa molto particolare: creare un sonetto su un tema a piacere. Si trattava di comporre quattro strofe, due di quattro righe e altre due di tre righe, tutte in endecasillabi, cioè in versi di undici sillabe ciascuno e con le rime da rispettare secondo certe regole alle quali prestai molta attenzione. Il giorno dopo fummo invitati a leggere a turno le nostre opere. Prima che toccasse a me si alzò uno dei miei compagni e lesse la sua. Ero ammirato e sorpreso come gli altri e alla fine si levò dalla classe un gran brusio di approvazione. Poi fu la volta mia e anche se non ero bravo nella recitazione il mio lavoro raccolse un discreto consenso. Il compagno che mi aveva preceduto non si aspettava che fossi un concorrente temibile dal momento che in italiano prendevo appena la sufficienza. Così davanti a tutti mise in dubbio che fosse farina del mio sacco. Il professore, che conosceva a memoria la maggior parte delle poesie più popolari, riuscì invece a fare ammettere all’incauto poeta che proprio i suoi versi tanto lodati erano stati copiati parola per parola e rima per rima. Io fui apprezzato per la capacità con cui avevo saputo rispettare le regole ma non per il contenuto dei versi. Forse il Prof non si era fidato fino in fondo neanche di me e dell’autenticità della mia ispirazione. O forse avevo scritto solo delle cose banali anche se in una forma corretta.
Nel 1960 all’età di undici anni decisi di mettere la musica al testo di una mia poesia e da quel momento diventai senza saperlo un cantautore. Fu in quella veste che a fine settembre del 1976 mi presentai a Mario Cantini, direttore delle edizioni RCA, con un nastro di dieci canzoni realizzate in casa su uno dei primi registratori con cui era possibile fare sovraincisioni e missaggi artigianali. Al termine dell’audizione Cantini, che aveva gradito i miei testi ma non era entusiasta della mia vena musicale, mi propose di scegliere tra due strade: entrare nel gruppo dei “Pandemonium”, di cui aveva fatto parte anche Amedeo Minghi, o nella squadra di Roberto Davini, produttore interno, per scrivere testi. Da buon individualista scartai l’ipotesi del gruppo e iniziai la mia attività di paroliere pur senza abbandonare le aspirazioni da cantautore e da musicista.
Per questo lavorando a “L’isola del tesoro” mi detti da fare con il pianoforte e con la chitarra in ogni momento libero dall’impiego di grafico pubblicitario che mi dava da vivere. Inventai tre diversi motivi e scrissi tre testi. Registrai il brano più accattivante e lo portai a Olimpio, che sembrò mostrare un certo interesse anche se limitò al minimo i commenti prima di affiancarlo alle altre “Isole” già allineate sulla scrivania. Il miraggio di una sigla in RAI aveva stimolato la creatività di molti e qualcuno era stato più veloce di me. Due giorni dopo nello stesso ufficio ascoltavo il provino di Dougie e Mike: un altro mondo, felice, sognante e vincente come tutti i loro brani. Misi da parte le mie velleità di musicista e mi accordai sui tempi di consegna delle parole che avrei scritto per rientrare in gara grazie ai Rocking Horse.
A quei momenti di eccitazione e di attività intensa seguì un lungo periodo di calma. La grande goletta Hispaniola, il pirata Long John Silver con una sola gamba, il giovane Jim e il terribile capitano Flint con il suo tesoro erano tornati a vivere nel paese dell’avventura e delle leggende. Alla stessa remota dimensione, molto più distante degli anni trascorsi, sembrava appartenere lo sceneggiato a puntate “L’isola del tesoro” messo in onda dalla RAI nel 1959.
Una domenica verso ora di pranzo lo squillo del telefono e la voce di Dougie dall’altra parte del filo ricomposero in un attimo nella mia mente tutte le immagini create dalla fantasia di Stevenson. Olimpio Petrossi e Mario Cantini stavano per decidere il destino della nostra “Isola” e avevano urgente bisogno di un provino con il testo. Il nastro con la base era a casa di Mike Fraser, Mike era fuori Roma e la demo doveva essere sul tavolo di Cantini per il lunedì mattina seguente, altrimenti saremmo stati fuori tempo massimo e quindi fuori dal gioco. Io possedevo un impianto di registrazione semiprofessionale che mi era costato quasi lo stipendio di un anno e che avevo comprato per non essere da meno dei grandi autori se non altro nella qualità delle incisioni. Se ero d’accordo Dougie sarebbe venuto con Dave a casa mia e in poche ore avremmo registrato le chitarre, la batteria e le voci.
“Dai, Lucio! Famo tutto, vedrai! Oh… ce l’hai la chitarra? Dave, la sua, l’ha lasciata da Mike”
“Sì, una Yamaha dodici corde e una Di Giorgio classica da studio”
“La dodici corde va bene! E la chitarra elettrica?”
“Elettrica? Ce l’ho, ma è vecchissima”. Era una quattro magneti, un modello da night degli anni cinquanta, con i lustrini sulla cassa armonica per fare atmosfera. “I miei amici dicono che sembra una radio. E poi smiagola, non tiene l’accordatura. No, Dougie. Non ci si può suonare…”
“O Key! O key! Lucio, poi vedemo”
Dave e Dougie arrivarono alle quattro del pomeriggio. Le finestre dell’appartamento al primo piano affacciavano su una strada tranquilla di Monte Mario, una piccola via privata tra i giardini condominiali, senza negozi e con un passaggio di auto inesistente. Nei giorni di festa solo il canto di qualche uccellino avrebbe potuto raggiungere i microfoni. Un paio d’anni prima, quando oltre alla piastra a cassette avevo un normalissimo registratore stereo a bobine, realizzavo i miei provini chitarra e voce, senza poter correggere. Se prendevo male un accordo o sbagliavo una parola dovevo ricominciare tutto daccapo. Una sera, a metà della registrazione di un brano, sentii un improvviso trambusto che veniva dal giardino: rumore di foglie secche e di arbusti spezzati e il soffiare di un gatto contro il suo assalitore, un cane che abbaiando si era lanciato all’inseguimento. La mia interpretazione era però ben riuscita e preferii tenerla con quegli attimi di caos in sottofondo. Ora, se un simile inconveniente si fosse ripetuto, le apparecchiature di cui disponevo avrebbero consentito di rimediare. Nemmeno tutti i cani e i gatti del quartiere ci avrebbero fermato.
Ero con Rosy, la mia ragazza, e la sua amica Donatella. Saremmo dovuti andare al cinema e invece assistemmo a una storica prova dei due Rocking Horse e alla rinascita della mia vecchia Eko sotto le mani di Dave. La batteria, da registrare per prima, era una “Korg rhythm 55” elettronica, che oggi susciterebbe curiosità e divertimento in un museo di strumenti musicali post-moderni. Quarantotto ritmi preconfezionati, dal foxtrot alla disco, con le sole opzioni di poter variare il volume dei singoli componenti, cassa, rullante, piatti ecc. e di regolare la velocità e lo swing. L’èra del digitale e dei computer era ancora agli inizi e la prima magia di quella domenica di novembre del 1981 la fece Dougie, che con un mezzo evoluto per l’epoca ma ancora molto limitato nelle possibilità, creò in dieci minuti il disegno ritmico che il batterista Marvin Johnson avrebbe realizzato in studio.
Dougie è una persona amabile. Dovunque vada, arriva prima di lui il suo buonumore, la disponibilità a trovare subito un’intesa con chi gli sta intorno. Per chiunque non sia un pezzo di marmo è difficile rimanere indifferente al clima di gioco e divertimento che è capace di creare anche quando c’è da lavorare sul serio. Perciò con due tipe come Rosy e la sua amica, a cui in certi giorni bastava guardarsi per scoppiare a ridere, tutto poteva accadere. E successe che Rosy e Donatella per le battute a ripetizione di Dougie non riuscivano a smettere di sghignazzare nemmeno quando la luce rossa imponeva il silenzio più assoluto. Io che manovravo il TEAC a quattro piste alla fine mi arresi e, sapendo di poterla escluderla al momento del missaggio, lasciai registrata l’ennesima risata esplosa proprio mentre l’eterno ragazzo di Liverpool scandiva con la voce lo starter del brano.
Dave Sumner suonò in modo miracoloso. Non ci potevo credere: nelle sue mani la mia vecchia chitarra si rianimò di nuova vita attraversata dall’energia e dall’estro che fluivano nei circuiti elettrici e nelle corde d’acciaio docili al tocco di uno dei migliori chitarristi rock presenti in Italia.
La performance musicale fatta in casa servì a tenere in gara la nostra canzone ma non sciolse i dubbi dell’Editore. Un altro brano, firmato da Stefano Jurgens e da Argante (pseudonimo di Massimo Cantini, autore de “Il Grande Mazinger”) fu apprezzato almeno quanto il nostro. Nell’indecisione fu stabilito di mandare in sala tutti e due i contendenti: Dougie, Mike, Dave, Marvin e Mick nello studio “D”, Massimo Cantini con Lino Toffolo e una squadra di turnisti nello studio “C” esattamente di fronte. Credo sia stato l’unico avvenimento del genere nella storia delle sigle edite dalla RCA.
Vinsero gli altri e per noi fu una forte delusione. Resta inspiegabile la ragione di una gara portata all’estremo tra due brani tanto diversi, un rock e una marcetta, un gruppo di professionisti della musica in alternativa a un attore cabarettista che ogni tanto cantava recitando. Sono tuttora convinto che la scelta si potesse fare semplicemente sulla base dei provini. Olimpio sostiene che la decisione finale fu del funzionario Rai responsabile della messa in onda dei cartoni e che probabilmente fu la maggiore notorietà di Toffolo a fare la differenza. Una piccola curiosità di quei giorni: Dougie, quando non era impegnato con la sua “Isola”, entrava nello studio “C” e dava una mano agli avversari prestando la sua voce come corista. Non ho mai chiesto a Olimpio cosa ne pensasse, se cioè si fosse sentito in imbarazzo di fronte a una simile cavalleresca generosità o se a cose fatte si limitò a verificarne il risultato artistico. Né chiederò mai a Dougie se per quel turno extra fu pagato da qualcuno.
Un anno e mezzo dopo, a maggio del 1983, la RCA ci assegnò il premio di consolazione. Tirò fuori dal frigorifero il nastro della nostra “Isola del tesoro” e lo riciclò per “Il Dr. Slump e Arale”. Andai, unico invitato, nella solita sala riunioni, presi i miei appunti guardando un quarto d’ora del filmato e scrissi il nuovo testo che raccontava dello scienziato pasticcione inventore di Arale, la bambina robot. Anche Dougie lavorò in splendida solitudine, unico Rocking Horse a tornare in studio accompagnato da Olimpio. Per la sigla di “Slump” sarebbe stata utilizzata la base musicale dell’Isola senza alcuna modifica e la presenza degli altri del gruppo era superflua. Per cantare bastava Dougie e per i cori si sarebbe deciso sul momento se fossero sufficienti le sue sovrapposizioni o se si dovessero chiamare Marcello Cirillo o Lorenzo Meinardi. Il primo aveva già cantato in “Lulù” e il secondo proprio l’anno prima aveva scritto e interpretato “Lalabel” con Dougie. Gli studi RCA erano tutti occupati e fu affittato il “Mammouth” di Bobby Solo, un ex casale alle porte di Roma sulla via Aurelia trasformato in sala di registrazione dall’interprete di “Una lacrima sul viso”.
Dougie dimostrò ancora una volta di essere un vocalist eccellente. Anche ora riascoltando “Il Dottor Slump e Arale” e “L’isola del tesoro” non trovo differenze pur minime di qualità, timbro, limpidezza e divertimento tra le due interpretazioni. Confesso di non essermi mai affezionato nemmeno un po’ alla sigla di “Slump”. Il personaggio del cartone è simpaticissimo e credo sia rimasto nel cuore di tanti fan così come spero di avere scritto un testo dignitoso, ma nel mio cuore sono rimasti Long John Silver, Jim, il capitano Flint, l’Hispaniola, il monte Cannocchiale e la mappa del tesoro nati dalla fantasia di Robert Louis Stevenson. Dopo tanti anni mi è rimasto un po’ di amaro in bocca che non se ne vuole andare. Strano, in fondo non fu l’unica e nemmeno la più grande delusione nella mia attività di paroliere. La spiegazione forse sta nel fatto che di quell’isola mi ero innamorato poco più che bambino e le immagini dei pirati e del mare in tempesta, del fortino e della spiaggia, della locanda e del pappagallo sulla spalla dell’uomo con una gamba sola avevano lasciato nella mia mente un’impronta indelebile. In bianco e nero. Come la televisione degli anni cinquanta.
Un giorno Dougie mi ha detto di non avere mai litigato con nessun compagno di lavoro in tutta la sua lunga carriera. E mi ha ricordato di avere cantato tutto quello che scrivevo per i Rocking Horse senza obiezioni sulle difficoltà di pronuncia. Io del resto mi immedesimavo in lui per quanto mi era possibile scegliendo le parole più semplici e musicali per un inglese che parlava meglio il romanesco che l’italiano. Ciò nonostante ci fu tra noi un momento di tensione a distanza causato dalle sillabe Dot – tor – Slump, già difficili da articolare senza l’aggravio del ritmo e della linea melodica e che ogni volta lo facevano impuntare. Olimpio ricorda che Dougie, dopo qualche tentativo mal riuscito, si irritò e non voleva più andare avanti. Fatto del tutto inusuale per lui, si dava arie da vera star e si rifiutava di cantare. Io non ero presente e toccò a Olimpio usare ogni strumento della diplomazia, compresa una breve pausa al bar, per spiegare a Dougie che avevo fatto del mio meglio e che non esisteva una collocazione migliore per quelle tre sillabe quasi impossibili.
Grazie a quella fortunata mediazione considerammo chiuso il tormentato capitolo “Isola del tesoro – Dr. Slump e Arale”. Ma nessuno di noi poteva prevedere che le canzoni di quei giorni e le altre che avremmo composto nei mesi successivi stavano lasciando tanti piccoli segni nella memoria e nel cuore di chi guardava la tivù. Nessuno poteva immaginare che tanti anni dopo i bambini di allora avrebbero considerato i nostri 45 giri degli oggetti di culto, che avrebbero ballato con le nostre canzoni nelle “Notti delle Sigle” di Roma e Milano dal 2000 in poi, che ci avrebbero fotografato, premiato, chiesto autografi e interviste e soprattutto ringraziato per la musica e le parole che avevamo scritto. E tanto meno avremmo mai creduto, io, Mike, Dougie e Olimpio, che nel 2003 l’ex RCA, poi BMG Ricordi e oggi Universal Music, avrebbe pubblicato un CD della serie “TiVulandia” con l’amatissima e sfortunata versione de “L’isola del tesoro” dei Rocking Horse. Un riconoscimento tardivo avviato comunque verso un destino travagliato.
Febbraio 2003. Squilla il telefono, è Olimpio. Di tanto in tanto mi chiama, siamo rimasti amici, anzi a dire il vero lo siamo diventati dopo che nel 1993 lasciò la RCA. Prima eravamo semplicemente un autore di belle speranze e un produttore tra i più stimati che lavoravano insieme anche per due o tre brani di seguito e poi si perdevano di vista per mesi. Peraltro alcuni, forse invidiosi dei nostri successi, fecero girare voci su un presunto rapporto privilegiato, frutto di chissà quali accordi o tangenti tra lui e i Rocking Horse. Forse c’era chi aveva notato la bottiglia di Ballantine’s che una volta l’anno alla vigilia di Natale gli lasciavo sulla scrivania? Forse aveva colto Dougie in flagrante mentre gli offriva una birra? Oppure aveva visto Mike o Dave dargli una sigaretta alle due di notte alla fine di un turno per il quale Olimpio non avrebbe preso nemmeno un’ora di straordinario?
Dunque mi chiama Olimpio al telefono e mi racconta che un fan gli ha appena manifestato tutto il suo disappunto per un errore macroscopico nelle note di copertina del CD “TiVulandia Volume 5” uscito in quei giorni. La quinta traccia è indiscutibilmente “L’isola del tesoro” dei Rocking Horse ma nel retro in corrispondenza del numero cinque si legge: “L’isola del tesoro”; interpreti: Rocking Horse; autori: S.Jurgens – Argante; arrangiamento: Aldo Tamborrelli.
“Guarda che il CD ce l’ho anch’io.” gli dico. L’avevo comprato per averlo come ricordo visto che conteneva due sigle mie “Ultralion” e “All’età della pietra” ma non gli avevo ancora tolto il cellophane. “Sul CD c’è anche “L’isola del tesoro”, ma è quella di Massimo Cantini.”.
“No, non è quella di Massimo, è la tua.”.
“Olimpio, ti pare che fanno uscire una canzone dopo vent’anni? E poi non è mai stata usata come sigla. Quel ragazzo si è sbagliato.”.
Per provarlo tolgo il cellophane, metto il disco nel lettore, seleziono “5” e parte la voce di Dougie all’unisono con la chitarra di Dave. Pazzesco, è proprio la nostra “Isola” attribuita ad altri.
Il giorno dopo chiamo la BMG e chiedo di un dirigente di cui Olimpio mi ha dato il nome. Gli chiedo spiegazioni e se c’è modo di rimediare. È l’inizio di un’avventura che durerà circa sei mesi. Parlo con il dirigente, poi con un impiegato e con un suo collega. Mi viene detto di rivolgermi agli uffici di Milano che mi dirottano nuovamente su quelli di Roma. Quando, dopo altri tentativi, comprendo che sto inutilmente misurandomi col muro di gomma della burocrazia e del menefreghismo decido di scrivere alla Società Italiana degli Autori e Editori, spiegando il caso, elencando i miei passi infruttuosi con la BMG Ricordi e chiedendo aiuto. Ed è soltanto grazie alla S.I.A.E. che la vicenda arriva al lieto fine. Finalmente vengo contattato dalla funzionaria della BMG che aveva redatto la compilation e che si scusa con me. Mi spiega che la casa discografica si era accorta del rinnovato interesse del pubblico per le vecchie sigle tivù – inediti compresi – e che aveva deciso di mettere in commercio un nuovo TiVulandia con la nostra versione mai pubblicata.
Prima della fine del 2003 il “TiVulandia 5” fu ristampato con le note di copertina corrette e distribuito nei negozi.
Forse un giorno grazie a quel fan il CD contestato diventerà una rarità contesa dai collezionisti come il famoso “Gronchi rosa”, un francobollo degli anni sessanta che in conseguenza di un errore di stampa fu ritirato dal mercato e salì a quotazioni da capogiro, e io potrei ritrovarmi con una piccola fortuna, la fortuna che “L’isola del tesoro” di Macchiarella – Meakin – Fraser non ebbe mai.